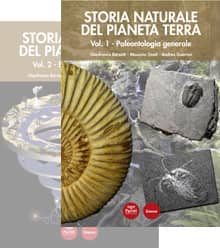Acta Apuana XVI-XVII (2017-2018) – Studi in memoria di Maria Ansaldi (1959-2013)
Volume Il prezzo originale era: 10,00€.9,50€Il prezzo attuale è: 9,50€.
Informazioni tecniche
Descrizione
«Acta apuana mostra oggi la sua veste più tradizionale con questo numero miscellaneo di studi naturalistici, riproponendo il “taglio compositivo” che fu di altri numeri, ad iniziare dal primo nell’ormai lontano 2002. La rivista ritorna dunque all’antico sulla soglia dei primi venti anni di vita, quasi a ricordare che ogni esperienza editoriale deve pur sempre farsi riconoscere per l’autenticità del suo conio originale. L’imprinting non si logora del tutto, perché è fatto di segni e tratti tipici che persistono nonostante l’usura del tempo, le congiunture, le mode e gli interessi del momento.
Acta apuana ha comunque sperimentato molto in questo suo primo ventennio di attività. Il ricorso a numeri monografici, talvolta di argomento diverso e distante dal più classico ambito delle Scienze naturali, è stato un sentiero assai battuto dalla rivista, che ha permesso di raggiungere obiettivi di maggior interesse di pubblico. Questo debordare oltre il primo argine di fondazione è servito a stimolare un più ampio ventaglio di studi e ricerche sulla complessa e multiforme realtà delle Alpi Apuane. Tale scelta è stata pure utile per far affluire ulteriori contributi culturali nell’alveo della conoscenza di questo territorio e raccogliere così risultati inattesi o altrimenti destinati ad un futuro ancora ulteriore. Sono state così coinvolte discipline apparentemente distanti tra di loro e talora attribuite alla riva, ritenuta opposta, delle Scienze umane.
Per Acta apuana non esiste una barriera o una frattura tra sapere scientifico e sapere umanistico: non c’è assolutamente un dualismo, ma un binomio che è vera sintesi. Tutte le scienze hanno pari dignità, poiché il progresso tecnico ed economico di ogni luogo del pianeta è imprescindibile dalla crescita culturale degli individui e delle collettività che vi abitano. Nello stesso modo e nelle stesse proporzioni, un Parco deve fondare il proprio agire attraverso le conoscenze acquisite con metodo e rigore, gestendo il territorio protetto nel rispetto delle espressioni e sensibilità delle comunità residenti.
Non a caso, questo ultimo volume di Acta apuana viene dopo il numero monografico di Storia dell’arte, dedicato alla cultura del marmo tra Medioevo e Rinascimento. Segue inoltre, precedenti volumi interamente riservati al dossier di candidatura alla Rete globale ed europea dei Geoparchi e, ancora prima, gli studi condotti sul Complesso carsico del monte Corchia. Bisogna così risalire a otto anni fa per ritrovare un numero di miscellanea naturalistica analogo al presente. Era il luglio 2013 quando usciva Acta apuana IX-X, che il Parco dedicava alla figura indimenticata del suo presidente Giuseppe Nardini, scomparso appena un anno prima. Il caso ha voluto che, nello stesso volume, fosse presente l’ultimo lavoro di Maria Ansaldi, scritto insieme ad Alessandro Bizzarri e Natale Emilio Baldaccini, sulla presenza e sulla biologia riproduttiva del gracchio alpino e corallino nelle Alpi Apuane. Il piccolo segno tipografico dell’òbelo, posto in apice dopo il nome dell’autrice, avvertiva i lettori della sua immatura perdita, avvenuta il giorno 18, proprio nello stesso mese e nello stessa anno della pubblicazione.
Maria Ansaldi non ha avuto modo di sfogliare quel numero della rivista e non ha così potuto provare di nuovo il piacere unico che ognuno di noi rinnova quando può leggere la stampa definitiva di un proprio scritto. Quasi a risarcirla di questa soddisfazione negata, Acta apuana dedica alla sua memoria di donna e di scienziata, oltre che di amica vera, il presente numero miscellaneo di studi naturalistici.»
Il Direttore – Antonio Bartelletti
Scarica l’indice del volume (90 kb)
Maria Ansaldi nasce il 14 luglio 1959 a Canevara, una piccola frazione di Massa nel fondovalle del fiume Frigido, all’interno delle Alpi Apuane. Dopo il diploma di maturità scientifica al Liceo “Enrico Fermi” di Massa, si laurea nel 1984 in Scienze naturali all’Università di Pisa con il prof. Paolo Emilio Tomei, discutendo una tesi sulla flora e sulla vegetazione delle Rupi di Porta, poste tra Montignoso e Pietrasanta.
Naturalista appassionata, da sempre legata al proprio territorio, mette in mostra una preparazione non comune. Trova impiego stabile prima al Dipartimento di Scienze Botaniche e successivamente al Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. In trent’anni di attività di ricerca, conduce studi soprattutto floristici e vegetazionali, ma anche di micologia, etnobotanica, corologia, ecologia vegetale e conservazione della biodiversità e del germoplasma di specie endemiche e minacciate, senza dimenticare alcuni significativi lavori interdisciplinari che si estendono nel campo della zoologia. È autrice, insieme ad altri, di numerose pubblicazioni scientifiche, che hanno contribuito soprattutto alla conoscenza floristica delle Alpi Apuane. Tra questi lavori, è doveroso segnalare il riaccertamento della popolazione autoctona di Abies alba (1988), la scoperta di una stazione relitta di Rhododendron ferrugineum (2003) e la descrizione di due specie endemiche nuove – Pinguicula apuana e P. mariae (2009) – con la seconda a lei specificamente dedicata dal prof. Siegfried Jost Casper.
Anche la divulgazione è un aspetto fondante del suo scrivere. Per il Parco delle Apuane pubblica la guida illustrata sui fiori d’altitudine dell’area protetta (1994), mentre con il titolo Orecchiella, un parco dell’Appennino (1999) ci offre un manuale utile alla visita della stessa riserva naturale.
Uno spazio significativo dei propri interessi professionali lo dedica ai giardini alpini, dando sviluppo a quell’attività che ha iniziato ad apprendere, ancora studentessa, presso l’Orto Botanico di Pian della Fioba a Massa. Di questo importante centro di conservazione della flora apuana, diviene curatrice appassionata ed instancabile promotrice delle attività educative verso i visitatori e le scuole. Stesso ruolo svolge per l’Orto botanico della Pania di Corfino, collaborando stabilmente anche con l’analogo giardino alpino dell’Abetone.
Partecipa ai lavori ed è socia di varie istituzioni e associazioni scientifiche, tra cui la Società Botanica Italiana, la Società Toscana di Scienze Naturali, l’Associazione Italiana Giardini Botanici Alpini, il Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee.
Muore a Massa il 18 luglio 2013.
.