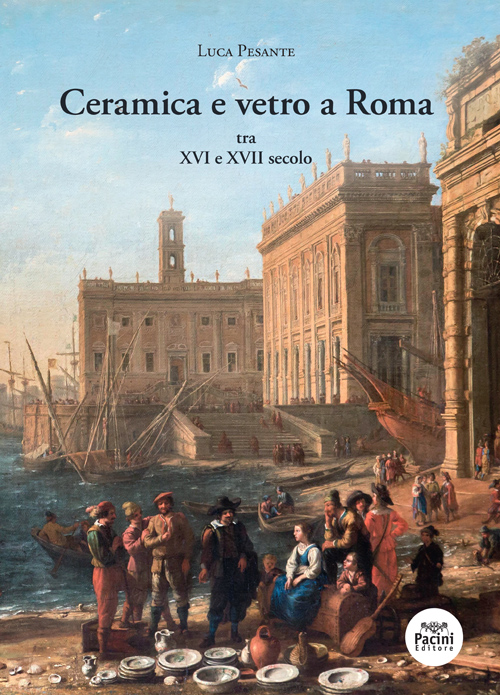
Ceramica e vetro a Roma
tra XVI e XVII secolo
con un saggio di Carmen Ravanelli Giuidotti
Volume Il prezzo originale era: 22,00€.20,90€Il prezzo attuale è: 20,90€.
Informazioni tecniche
Descrizione
«In un giorno di marzo del 1581 così dovette apparire Roma agli occhi di un colto umanista francese: “questa città non ha quasi manovali e uomini che vivano del lavoro delle loro braccia, Roma è una città tutta corte e nobili. Ciascuno prende parte per conto proprio all’ozio ecclesiastico. Non vi sono strade di mercato…, non vi sono che palazzi e giardini”.
È vero, e con Montaigne anche Jean Delumeau ci aveva avvertito che la nostra indagine sarebbe potuta risultare deludente, eppure mettendoci sui passi di due gruppi di artigiani – proprio a partire dagli anni in cui l’illustre viaggiatore è nell’Urbe – si è svelata ai nostri occhi una realtà complessa, inattesa. Il centro europeo più cosmopolita, abitato in gran parte da forestieri, è apparso riflesso, nel nostro parziale e limitato punto di osservazione, nelle vite di quanti si occupavano nel lavoro dell’argilla e del vetro.
Ne è emerso il profilo di una città di circa 100.000 abitanti, crocevia di ampie rotte commerciali, dove la maggior parte dei maestri proveniva dai più noti luoghi di lavoro della Penisola. È ancora Montaigne che coglie immediatamente questo elemento affermando che Roma “c’est une ville rapiécée des étrangers, chacun y est comme chez soi”. La continua circolazione degli uomini rendeva possibile nuove sperimentazioni che non erano esclusivamente rivolte alla domanda di un circoscritto mercato interno. Al porto di Ripa Grande, ed è questo uno degli aspetti più inattesi emersi nel corso di questa ricerca, maioliche e vetri prodotti a Roma erano di frequente caricati su barche dirette a Napoli, in Calabria o in Sicilia. Al contempo nello stesso porto di Ripa giungevano materie prime dal litorale di Trapani – sabbia silicea – o da Altare, nell’entroterra savonese: soda, terra, semilavorati e strumenti per la lavorazione del vetro.
Il lavoro di questi due gruppi di maestri si intreccia continuamente nel corso degli anni qui presi in esame – all’incirca dal pontificato di Gregorio XIII fino alla peste del 1656 – come mostrano diverse controversie giudiziarie dove si dibatte perfino sulla corretta definizione dei mestieri del vascellaro e del bicchieraro, ma si lega di sovente anche ad altre forme d’arte. L’esempio di Nardo Cocchi è emblematico: originario di Piegaro in Umbria, diviene ben presto il principale produttore di vetro di tutto lo Stato Ecclesiastico e al tempo stesso impegnato sui cantieri dei grandi cicli musivi in San Pietro – e altrove – accanto a celebri pittori come Girolamo Muziano o Paolo Rossetti.
Per la maiolica Diomede Durante da Casteldurante compie un percorso simile, seppure più orientato entro l’orizzonte economico urbano. Entrambi ottengono l’ambita cittadinanza romana e lasceranno alla loro morte un cospicuo patrimonio agli eredi…»
L’Autore
Scarica l’intera Introduzione (86 kb)
Scarica l’indice del libro (16 kb)
.



















